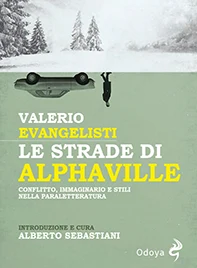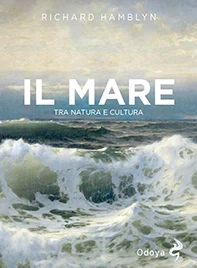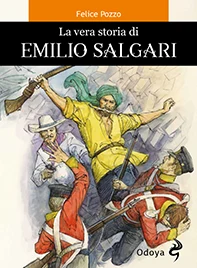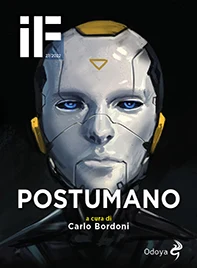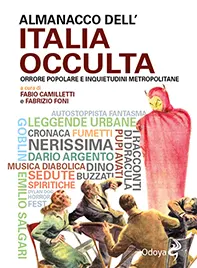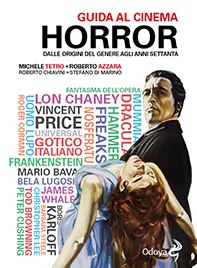Dylan Dog
Indocili sentimenti, arcane paure
Dylan Dog
Indocili sentimenti, arcane paure
Fin dal primo albo uscito nel 1986, Dylan Dog ha rappresentato uno spartiacque dell’immaginario collettivo. In brevissimo tempo è diventato un fenomeno di costume raggiungendo un milione di copie vendute e incarnando sogni, desideri, ansie, paure e speranze di un’intera generazione che si riconosceva in questo investigatore sui generis.
Dylan era altruista, romantico, idealista e soprattutto anticonformista; agli antipodi rispetto al modello culturale dominante dei “favolosi anni Ottanta” in cui le parole d’ordine erano successo, denaro, felicità, edonismo. Dylan era (ed è ancora) un “perdente” dal cuore d’oro. Le sue atmosfere cupe e surreali, le storie romantiche e disperate mettevano all’indice le ipocrisie di un’epoca che nel giro di pochi anni avrebbe visto crollare tutte le sue certezze e i suoi miti.
Attraverso gli interventi di sceneggiatori, docenti e studiosi di fumetto, questo libro affronta tutti i temi della poetica dylandoghiana – l’orrore, l’amore, il comico, il citazionismo, la rivoluzionaria modernità del linguaggio – e getta uno sguardo critico, ma non malinconico, su un’epoca di straordinaria creatività e innovazione.
Il volume è introdotto da una storica conversazione tra Tiziano Sclavi e Umberto Eco, in cui a ragionamenti letterari sulla “sgangherabilità” di Dylan Dog o alla sua appartenenza alle opere di culto si affiancano curiosità sull’occulto, sui processi di “regia” di Sclavi e sul suo rapporto con i disegnatori e con i fan.
Con una sceneggiatura originale di 16 tavole di Tiziano Sclavi.
“No accidenti! Ho bisogno di un mistero! Che cos’è la vita, la mia vita, senza la speranza che un incubo diventi realtà?”
– Dylan Dog
“Dylan è uno che qualche volta perde, oppure, se vince, non vince mai completamente. In fondo, non sembra neppure un eroe del fumetto. Le mie storie non sono mai consolatorie perché l’orrore non finisce. Si ricomincia sempre da capo”.
– Tiziano Sclavi
Umberto Eco
è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievista italiano. All’Università di Bologna è stato ordinario di Semiotica e tra gli ispiratori del corso di laurea DAMS, nonché direttore della rivista VS. Ha ricevuto quaranta lauree honoris causa. Tra le sue opere di saggistica ricordiamo Opera aperta (Bompiani, 1962), Diario minimo (Mondadori, 1963), Apocalittici e integrati (Bompiani 1964), La struttura assente (Bompiani, 1968), Lector in fabula (Bompiani, 1979), I limiti dell’interpretazione (Bompiani, 1990), Il secondo diario minimo (CLUEB, 1992), Kant e l’ornitorinco (Bompiani, 1997). Ha esordito nella narrativa, sempre per Bompiani, con Il nome della rosa (1980), vincitore del premio Strega e tradotto in oltre quaranta lingue, seguìto da Il pendolo di Foucault (1988) e da L’isola del giorno prima (1994). Per Bompiani sono usciti anche Baudolino (2000), Il cimitero di Praga (2010) e Numero zero (2015).Tiziano Sclavi
è il creatore di Dylan Dog. Tra i suoi romanzi ricordiamo: Tre (Camunia, 1988), Dellamorte Dellamore (Camunia, 1991), Nero (Camunia, 1992), Le etichette delle camicie (Giunti, 1996), Non è successo niente (Mondadori, 1998), Il tornado di valle Scuropasso (Mondadori, 2006). Ha vinto due volte il premio Anaf come miglior sceneggiatore di fumetti. Nel 1990, al Salone Internazionale dei Comics di Lucca, gli è stato assegnato lo Yellow Kid, Oscar mondiale del fumetto, quale migliore autore italiano.Giulio Giorello
è stato un filosofo, matematico, accademico ed epistemologo italiano. Ha ricoperto dal 1978 al 2015 la cattedra (già di Ludovico Geymonat) di Filosofia della scienza presso l’Università degli Studi di Milano; fu inoltre presidente della SILFS (Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza) dal 2004 al 2008. Ha diretto la collana “Scienza e idee” di Raffaello Cortina Editore e ha collaborato, come elzevirista, alle pagine culturali del Corriere della Sera. Ha vinto la IV edizione del Premio Nazionale Frascati Filosofia 2012, ed è stato attivo in rassegne culturali insieme allo scrittore Luca Gallesi. Ha pubblicato, tra le tante opere, Le ragioni della scienza (Laterza, 1986) con Ludovico Geymonat, Filosofia della scienza (Jacabook, 1992), La filosofia della scienza del XXsecolo (Laterza, 1999) con Donald Gillies, Il fuoco fatuo di Hobbes e il chiaro labirinto di Spinoza (2012), Il bene e il male. Dio, Arte, Scienza (La nave di Teseo, 2020) con Vittorio Sgarbi. Nel 2020 è uscito anche La filosofia di Tex e altri saggi. Dal fumetto alla scienza (Mimesis).Daniele Barbieri
si occupa di semiotica e comunicazione, con particolare attenzione al campo del visivo. Sul tema dei fumetti ha pubblicato i volumi Valvoforme e valvocolori (Idea Books, 1990) e I linguaggi del fumetto (Bompiani, 1991) e in materia di televisione Questioni di ritmo (Rai Libri, 1996). Nel campo della multimedialità ha progettato la struttura di Encyclomedia (1994-1998). Ha pubblicato il volume Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo (Bompiani, 2004) e ha curato La linea inquieta. Emozioni e ironia nel fumetto (Meltemi, 2005). Altre sue pubblicazioni sono: L’ascolto musicale. Condotte pratiche grammatiche (a cura di, con L. Marconi e F. Spampinato, lim, 2008), Breve storia della letteratura a fumetti (Carocci, 2009), Il pensiero disegnato. Saggi sulla letteratura a fumetti europea (Coniglio, 2010), Guardare e leggere. La comunicazione visiva dalla pittura alla tipografia (Carocci, 2011), Il linguaggio della poesia (Bompiani, 2011), Maestri del fumetto (Tunuè, 2012) e Semiotica del fumetto (Carocci, 2017).Collabora al supplemento culturale de Il Sole 24 Ore. Attualmente insegna all’isia di Urbino, all’Università di San Marino e all’Accademia delle Belle Arti di Bologna.
Fausto Colombo
insegna Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa all’Università Cattolica di Milano, di cui è direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo. Dirige il Master in Comunicazione, marketing digitale e pubblicità interattiva. È autore, tra l’altro, di Ombre sintetiche. Saggio di teoria dell’immagine elettronica (Liguori, 1990), Le nuove tecnologie della comunicazione (con Gianfranco Bettetini, Bompiani, 1993), La cultura sottile (Bompiani, 1998), La digitalizzazione dei media (a cura di, Carocci 2007), Boom. Storia di quelli che non hanno fatto il ’68 (Bompiani, 2008), Il Paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso (Laterza, 2012) e Imago Pietatis. Indagine su fotografia e compassione (Vita e Pensiero, 2018).Fabrizio Foni
è senior lecturer del Dipartimento d’Italiano e membro dell’Istituto di Studi Anglo-italiani presso la University of Malta. Si occupa primariamente di cultura popolare, con un occhio di riguardo per il soprannaturale, il gotico e il mostruoso.
Con Odoya ha curato, insieme a Fabio Camilletti, Almanacco dell’orrore popolare (2021) e Almanacco dell'Italia occulta (2022).
Marco Modenesi
è ricercatore e docente di Letteratura francese e Letterature francofone presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 2014 è direttore della rivista Ponti/Ponts. Langues, littératures, civilisations des Pays francophones, che raccoglie interventi a livello nazionale e internazionale relativi alla lingua, alle letterature e alle culture dell’universo francofono europeo ed extraeuropeo.Per EuresisEdizioni è stato tra i saggisti di Eroi di inchiostro. Antonio Serra racconta Nathan Never e Legs (1996).
Alberto Ostini
Lavora da oltre vent’anni per la Sergio Bonelli Editore, in particolar modo per le testate Dylan Dog e Nathan Never. È cosceneggiatore di Dampyr, lungometraggio tratto dall’omonimo fumetto. Ha lavorato per Rai e Mediaset ideando, tra l’altro, la serie I segreti di Borgo Larici.Tiene corsi di sceneggiatura all’Università Cattolica e all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico. È socio fondatore della Cooperativa Alchemilla con cui ha pubblicato due volumi illustrati per bambini: Artoo&Margherita e l’angelo apprendista e La meraviglia del buio.
Stefano Piani
è uno sceneggiatore e fumettista italiano. Ha scritto circa duecento storie a fumetti per la Sergio Bonelli Editore, per le testate: Nathan Never, Legs Weaver, Nick Raider, Dampyr e Dylan Dog.Per la televisione ha sceneggiato episodi di serie televisive come Elisa di Rivombrosa e Incantesimo ed è autore delle prime tre stagioni italiane de Il Commissario Rex, di Sei passi nel giallo e, insieme ad Alberto Ostini, de I segreti di Borgo Larici. Per il cinema ha scritto Dracula 3D di Dario Argento, Ho amici in paradiso di Fabrizio Maria Cortese e Il cinema non si ferma di Marco Serafini. Tiene corsi di sceneggiatura all’Università del Molise (UniMol) e all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma.
Paolo Vinçon
ha conseguito un dottorato di ricerca in Semiotica all’Università degli Studi di Bologna, con una tesi dal titolo Il testo narrativo e la trascendenza testuale in Dylan Dog, con relatore Umberto Eco. Insegna materie letterarie al liceo e tiene corsi di scrittura.Prefazione alla nuova edizione
di Alberto Ostini
Filosofare con Dylan Dog
di Giulio Giorello
Umberto Eco e Tiziano Sclavi. Un dialogo
Fausto Colombo
L’amore ai tempi della collera. Il sentimentale in Dylan Dog
Tra cult e best seller
Dal genere come formula alla formula come genere
Il sentimentale: un’estetica dello smarrimento
Stefano Piani
Sotto il letto di Susanna. Orrore e paura in Dylan Dog
La paura di creature minacciose
La paura di essere abbandonati
La paura della morte
La paura del buio
Alberto Ostini
Incubi di bordo. Viaggiare in Dylan Dog
Partenza?
Terre (im)possibili
Varchi
Altri mari, dentro
L’ultimo (?) viaggio
Daniele Barbieri
Racconti di racconti
Paolo Vinçon
Tutto il cinema in un fumetto
Roberto Favaro
L’ascoltatore dell’incubo.
Rumori, voci e musiche in Dylan Dog
Musica come ricerca dell’ignoto
L’ascolto del e nel fumetto
Rumori e voci
La colonna sonora del fumetto
Spazio e tempo virtuali: in navigazione con dischi, radio e pietre sonanti
La musica del fumetto
Marco Modenesi
Gli amici esistono per fare cose inutili. Groucho, come e perché
La parola di Groucho
L’essere di Groucho
Apologia del buffone
Fabrizio Foni
Di maschere della provincia e di schermi londinesi
Era morta
Storia completa di 16 tavole
Soggetto e sceneggiatura di Tiziano Sclavi
Note
Bibliografia essenziale
Note biografiche
Fin dal primo albo uscito nel 1986, Dylan Dog ha rappresentato uno spartiacque dell’immaginario collettivo. In brevissimo tempo è diventato un fenomeno di costume raggiungendo un milione di copie vendute e incarnando sogni, desideri, ansie, paure e speranze di un’intera generazione che si riconosceva in questo investigatore sui generis.
Dylan era altruista, romantico, idealista e soprattutto anticonformista; agli antipodi rispetto al modello culturale dominante dei “favolosi anni Ottanta” in cui le parole d’ordine erano successo, denaro, felicità, edonismo. Dylan era (ed è ancora) un “perdente” dal cuore d’oro. Le sue atmosfere cupe e surreali, le storie romantiche e disperate mettevano all’indice le ipocrisie di un’epoca che nel giro di pochi anni avrebbe visto crollare tutte le sue certezze e i suoi miti.
Attraverso gli interventi di sceneggiatori, docenti e studiosi di fumetto, questo libro affronta tutti i temi della poetica dylandoghiana – l’orrore, l’amore, il comico, il citazionismo, la rivoluzionaria modernità del linguaggio – e getta uno sguardo critico, ma non malinconico, su un’epoca di straordinaria creatività e innovazione.
Il volume è introdotto da una storica conversazione tra Tiziano Sclavi e Umberto Eco, in cui a ragionamenti letterari sulla “sgangherabilità” di Dylan Dog o alla sua appartenenza alle opere di culto si affiancano curiosità sull’occulto, sui processi di “regia” di Sclavi e sul suo rapporto con i disegnatori e con i fan.
Con una sceneggiatura originale di 16 tavole di Tiziano Sclavi.
“No accidenti! Ho bisogno di un mistero! Che cos’è la vita, la mia vita, senza la speranza che un incubo diventi realtà?”
– Dylan Dog
“Dylan è uno che qualche volta perde, oppure, se vince, non vince mai completamente. In fondo, non sembra neppure un eroe del fumetto. Le mie storie non sono mai consolatorie perché l’orrore non finisce. Si ricomincia sempre da capo”.
– Tiziano Sclavi
Prefazione alla nuova edizione
di Alberto Ostini
Filosofare con Dylan Dog
di Giulio Giorello
Umberto Eco e Tiziano Sclavi. Un dialogo
Fausto Colombo
L’amore ai tempi della collera. Il sentimentale in Dylan Dog
Tra cult e best seller
Dal genere come formula alla formula come genere
Il sentimentale: un’estetica dello smarrimento
Stefano Piani
Sotto il letto di Susanna. Orrore e paura in Dylan Dog
La paura di creature minacciose
La paura di essere abbandonati
La paura della morte
La paura del buio
Alberto Ostini
Incubi di bordo. Viaggiare in Dylan Dog
Partenza?
Terre (im)possibili
Varchi
Altri mari, dentro
L’ultimo (?) viaggio
Daniele Barbieri
Racconti di racconti
Paolo Vinçon
Tutto il cinema in un fumetto
Roberto Favaro
L’ascoltatore dell’incubo.
Rumori, voci e musiche in Dylan Dog
Musica come ricerca dell’ignoto
L’ascolto del e nel fumetto
Rumori e voci
La colonna sonora del fumetto
Spazio e tempo virtuali: in navigazione con dischi, radio e pietre sonanti
La musica del fumetto
Marco Modenesi
Gli amici esistono per fare cose inutili. Groucho, come e perché
La parola di Groucho
L’essere di Groucho
Apologia del buffone
Fabrizio Foni
Di maschere della provincia e di schermi londinesi
Era morta
Storia completa di 16 tavole
Soggetto e sceneggiatura di Tiziano Sclavi
Note
Bibliografia essenziale
Note biografiche
Umberto Eco
è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievista italiano. All’Università di Bologna è stato ordinario di Semiotica e tra gli ispiratori del corso di laurea DAMS, nonché direttore della rivista VS. Ha ricevuto quaranta lauree honoris causa. Tra le sue opere di saggistica ricordiamo Opera aperta (Bompiani, 1962), Diario minimo (Mondadori, 1963), Apocalittici e integrati (Bompiani 1964), La struttura assente (Bompiani, 1968), Lector in fabula (Bompiani, 1979), I limiti dell’interpretazione (Bompiani, 1990), Il secondo diario minimo (CLUEB, 1992), Kant e l’ornitorinco (Bompiani, 1997). Ha esordito nella narrativa, sempre per Bompiani, con Il nome della rosa (1980), vincitore del premio Strega e tradotto in oltre quaranta lingue, seguìto da Il pendolo di Foucault (1988) e da L’isola del giorno prima (1994). Per Bompiani sono usciti anche Baudolino (2000), Il cimitero di Praga (2010) e Numero zero (2015).Tiziano Sclavi
è il creatore di Dylan Dog. Tra i suoi romanzi ricordiamo: Tre (Camunia, 1988), Dellamorte Dellamore (Camunia, 1991), Nero (Camunia, 1992), Le etichette delle camicie (Giunti, 1996), Non è successo niente (Mondadori, 1998), Il tornado di valle Scuropasso (Mondadori, 2006). Ha vinto due volte il premio Anaf come miglior sceneggiatore di fumetti. Nel 1990, al Salone Internazionale dei Comics di Lucca, gli è stato assegnato lo Yellow Kid, Oscar mondiale del fumetto, quale migliore autore italiano.Giulio Giorello
è stato un filosofo, matematico, accademico ed epistemologo italiano. Ha ricoperto dal 1978 al 2015 la cattedra (già di Ludovico Geymonat) di Filosofia della scienza presso l’Università degli Studi di Milano; fu inoltre presidente della SILFS (Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza) dal 2004 al 2008. Ha diretto la collana “Scienza e idee” di Raffaello Cortina Editore e ha collaborato, come elzevirista, alle pagine culturali del Corriere della Sera. Ha vinto la IV edizione del Premio Nazionale Frascati Filosofia 2012, ed è stato attivo in rassegne culturali insieme allo scrittore Luca Gallesi. Ha pubblicato, tra le tante opere, Le ragioni della scienza (Laterza, 1986) con Ludovico Geymonat, Filosofia della scienza (Jacabook, 1992), La filosofia della scienza del XXsecolo (Laterza, 1999) con Donald Gillies, Il fuoco fatuo di Hobbes e il chiaro labirinto di Spinoza (2012), Il bene e il male. Dio, Arte, Scienza (La nave di Teseo, 2020) con Vittorio Sgarbi. Nel 2020 è uscito anche La filosofia di Tex e altri saggi. Dal fumetto alla scienza (Mimesis).Daniele Barbieri
si occupa di semiotica e comunicazione, con particolare attenzione al campo del visivo. Sul tema dei fumetti ha pubblicato i volumi Valvoforme e valvocolori (Idea Books, 1990) e I linguaggi del fumetto (Bompiani, 1991) e in materia di televisione Questioni di ritmo (Rai Libri, 1996). Nel campo della multimedialità ha progettato la struttura di Encyclomedia (1994-1998). Ha pubblicato il volume Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo (Bompiani, 2004) e ha curato La linea inquieta. Emozioni e ironia nel fumetto (Meltemi, 2005). Altre sue pubblicazioni sono: L’ascolto musicale. Condotte pratiche grammatiche (a cura di, con L. Marconi e F. Spampinato, lim, 2008), Breve storia della letteratura a fumetti (Carocci, 2009), Il pensiero disegnato. Saggi sulla letteratura a fumetti europea (Coniglio, 2010), Guardare e leggere. La comunicazione visiva dalla pittura alla tipografia (Carocci, 2011), Il linguaggio della poesia (Bompiani, 2011), Maestri del fumetto (Tunuè, 2012) e Semiotica del fumetto (Carocci, 2017).Collabora al supplemento culturale de Il Sole 24 Ore. Attualmente insegna all’isia di Urbino, all’Università di San Marino e all’Accademia delle Belle Arti di Bologna.
Fausto Colombo
insegna Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa all’Università Cattolica di Milano, di cui è direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo. Dirige il Master in Comunicazione, marketing digitale e pubblicità interattiva. È autore, tra l’altro, di Ombre sintetiche. Saggio di teoria dell’immagine elettronica (Liguori, 1990), Le nuove tecnologie della comunicazione (con Gianfranco Bettetini, Bompiani, 1993), La cultura sottile (Bompiani, 1998), La digitalizzazione dei media (a cura di, Carocci 2007), Boom. Storia di quelli che non hanno fatto il ’68 (Bompiani, 2008), Il Paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso (Laterza, 2012) e Imago Pietatis. Indagine su fotografia e compassione (Vita e Pensiero, 2018).Fabrizio Foni
è senior lecturer del Dipartimento d’Italiano e membro dell’Istituto di Studi Anglo-italiani presso la University of Malta. Si occupa primariamente di cultura popolare, con un occhio di riguardo per il soprannaturale, il gotico e il mostruoso.
Con Odoya ha curato, insieme a Fabio Camilletti, Almanacco dell’orrore popolare (2021) e Almanacco dell'Italia occulta (2022).
Marco Modenesi
è ricercatore e docente di Letteratura francese e Letterature francofone presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 2014 è direttore della rivista Ponti/Ponts. Langues, littératures, civilisations des Pays francophones, che raccoglie interventi a livello nazionale e internazionale relativi alla lingua, alle letterature e alle culture dell’universo francofono europeo ed extraeuropeo.Per EuresisEdizioni è stato tra i saggisti di Eroi di inchiostro. Antonio Serra racconta Nathan Never e Legs (1996).
Alberto Ostini
Lavora da oltre vent’anni per la Sergio Bonelli Editore, in particolar modo per le testate Dylan Dog e Nathan Never. È cosceneggiatore di Dampyr, lungometraggio tratto dall’omonimo fumetto. Ha lavorato per Rai e Mediaset ideando, tra l’altro, la serie I segreti di Borgo Larici.Tiene corsi di sceneggiatura all’Università Cattolica e all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico. È socio fondatore della Cooperativa Alchemilla con cui ha pubblicato due volumi illustrati per bambini: Artoo&Margherita e l’angelo apprendista e La meraviglia del buio.
Stefano Piani
è uno sceneggiatore e fumettista italiano. Ha scritto circa duecento storie a fumetti per la Sergio Bonelli Editore, per le testate: Nathan Never, Legs Weaver, Nick Raider, Dampyr e Dylan Dog.Per la televisione ha sceneggiato episodi di serie televisive come Elisa di Rivombrosa e Incantesimo ed è autore delle prime tre stagioni italiane de Il Commissario Rex, di Sei passi nel giallo e, insieme ad Alberto Ostini, de I segreti di Borgo Larici. Per il cinema ha scritto Dracula 3D di Dario Argento, Ho amici in paradiso di Fabrizio Maria Cortese e Il cinema non si ferma di Marco Serafini. Tiene corsi di sceneggiatura all’Università del Molise (UniMol) e all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma.
Paolo Vinçon
ha conseguito un dottorato di ricerca in Semiotica all’Università degli Studi di Bologna, con una tesi dal titolo Il testo narrativo e la trascendenza testuale in Dylan Dog, con relatore Umberto Eco. Insegna materie letterarie al liceo e tiene corsi di scrittura.-
Sede Legale
- Via Carlo Marx 21, 06012 - Città di Castello (PG)
- Tel +39 075.3758159 - Fax +39 075.8511753
- P. Iva 02774391201 - Scrivi una mail
-
Sede Operativa
- Via Pietro Mengoli 4, 40138 - Bologna (BO)
- Tel. +39 051.4853205